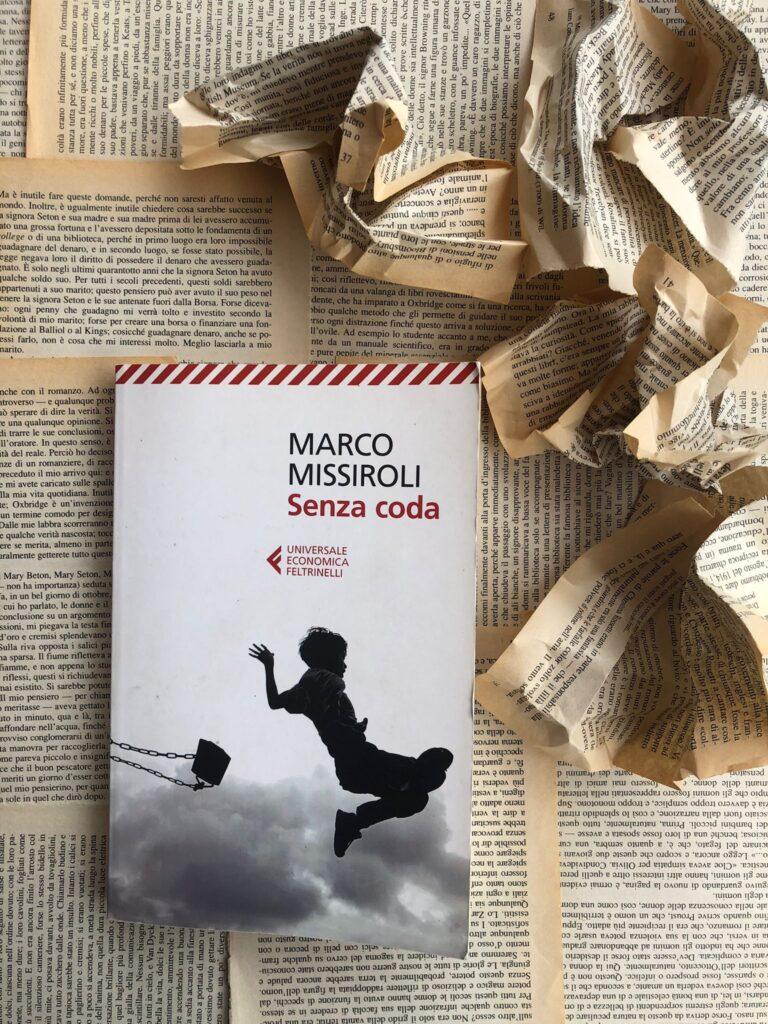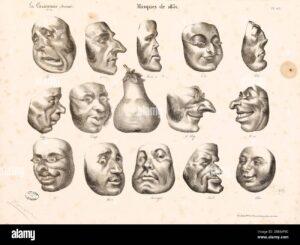Messico
di Ninni Caraglia
tratto dalla raccolta Tortelilini
a cura di Daniele Falcioni
ed. Rapsodia
L’ospedale aveva sei piani ed era tutto rivestito da vetri specchiati per riflettere le colline di querce e ontani che lo circondavano. Un bianco sentiero contornato da bosso e ginestre conduceva alla reception in stile alberghiero più che di struttura sanitaria. Anche la malattia deve avere la sua parte di bellezza per diminuire il dolore: su questo concetto il dottor Rifkin, fondatore, aveva concepito e costruito il suo ospedale per chi il dolore poteva eliminarlo con trasfusioni di dollari. L’ultimo piano era una top suite, sia per il paziente sia per chi soggiornava per assisterlo. Il piano sottostante dedicato agli uffici direzionali garantiva la privacy più assoluta; c’erano perfino due ascensori dedicati, uno esclusivo per il paziente ed uno per i sanitari.
La bionda e lentigginosa Linda Janssen era arrivata al Rifkin’s con la sua assistente Ana Sanchez il giorno prima, ovviamente in gran segreto per evitare il clamore della stampa. Linda e Ana erano coetanee, si erano conosciute al college e avevano mantenuto i contatti nonostante le loro vite completamente diverse. Ana era segretaria di direzione nel giornale della sua città: conosceva il mondo e la stampa; i “coccodrilli”, come diceva lei, crescevano in entrambi quei mondi e non solo nella sua Florida. Linda Janssen, bionda e procace, era in ogni foto del gruppo di cheerleader del college. Un sorriso fresco e una bella voce la portarono fino alla televisione: dai programmi per bambini a quelli del mattino, dove il suo sorriso apriva le finestre delle case di quella parte d’America che avevano cominciato a volerle un gran bene. Si ritrovarono quando Ana fu incaricata dal giornale di organizzare un’intervista a Linda. Quell’intervista ebbe molto successo, piacque come piacque a loro ritrovarsi. Decisero, dopo un paio di mesi, di continuare a lavorare insieme. Linda era serena, sapeva di poter contare sulla fiducia di Ana e a loro non interessavano i gossip dei rotocalchi su un presunto loro amore omosessuale. Affiatate ma diversissime nell’aspetto e nel carattere: Linda aveva giurato amore eterno alla sua bellezza e alla sua professione; Ana era di pelle dorata, dono del sole del Messico ai suoi nativi. Le canzoni di Linda risuonavano sempre nello studio di Ana e in mille altri sperduti motel, dove cameriere indaffarate cantavano quelle melodiche canzoni per divagarsi. “Ana, mi porteresti a trovare la tua famiglia in Messico? Ci meritiamo una vacanza”. Da allora, due volte l’anno si rifugiavano in un paesino sulla costa dell’Oceano Pacifico. C’era il giusto tempo per tutto: famiglia, sole, mare e anche il lavoro, visto che Linda aveva cominciato a pubblicare video sui social mentre cantava in spiaggia con i bagnanti. Linda non era abituata a vedersi così abbronzata, si vedeva più bella. Ana non era così amante del sole, quello del primo mattino era il suo vero caffè, poi era meglio lavorare all’ombra di casa.
Mentre disfacevano i bagagli nella suite dell’ospedale, ripensavano a quanti anni erano passati dalla prima vacanza in Messico, ormai la loro gioventù era trascorsa, per entrambe il successo professionale ed economico era al top. Le grandi vetrate del Rifkin’s sembravano membrane osmotiche per la luce del sole, che ora dava l’impressione di disturbarle. Le fronde ondeggiavano ipnotiche, assopite sui bianchi sofà.
Suonarono alla porta. Entrò un dottore con parecchi documenti in mano. “Buongiorno signora Janssen, mi chiamo Leonard Lewis e sarò il suo specialista dermatologo. Le lascio alcuni moduli da compilare e il calendario delle indagini che faremo in questi giorni. Si prenda del tempo per darci un’occhiata, può chiamarmi al 713 a qualsiasi ora”.
“La ringrazio, leggerò tutto subito e la richiamerò presto” rispose Linda stringendogli vigorosamente la mano per salutarlo.
“Ana, per favore, potresti ordinare in anticipo la cena? Così guardiamo insieme questi moduli” chiese sbuffando Linda. “Aggiungi anche una bottiglia di prosecco ben fresco!” aggiunse mentre disponeva sul tavolo i documenti.
“Alcol il giorno prima degli esami?” chiese stupita Ana.
“Ana, per favore! Ho già visto che il primo appuntamento, che fra l’altro è un semplice colloquio, è alle 11, quindi ho tutto il tempo per smaltire una bottiglia di prosecco. Anzi mezza, visto che beviamo insieme. Per favore! Già non dovrei essere qui! Sei stata tu ad insistere”.
Mentre Linda era di spalle, Ana alzò gli occhi al cielo e telefonò alla reception per ordinare.
La bottiglia di prosecco finì presto, Ana leggeva a Linda le domande del questionario anamnestico e poi scriveva subito la sua risposta. Ana evitava domande pensando che l’atteggiamento dell’amica fosse solo normale nervosismo. Due ore dopo telefonarono al dottor Lewis, che le raggiunse subito in stanza. Lewis era alto e ben piazzato, il camice bianco e gli occhiali tondi e dorati risaltavano sulla sua carnagione scura. Anzi, decisamente nera. Linda non era razzista ma quel colore la intimoriva. Ana gli fece cenno di accomodarsi al tavolo.
“Grazie per aver compilato tutto così presto. Leggerò e domani, se ne avrò bisogno, le farò altre domande. Domattina faremo un’epiluminescenza, una radiografia al torace e una biopsia. Se ci sono segnali dubbi faremo anche una tac. Meglio una cosa in più che una in meno, giusto? Tutto chiaro? Domande? Allora ci vediamo domani alle 11 al primo livello sotterraneo, stanza 10. Usi il suo ascensore e stia tranquilla, non la vedrà nessuno, anche se il nostro centralino oggi è andato in tilt per le telefonate dei giornalisti. Vi consiglio di usare la linea telefonica privata a voi dedicata. Buonanotte, signore”. Rimasero entrambe in silenzio sino al mattino successivo. Dopo gli esami del caso, pranzarono di gusto, visto che si era fatto tardi. Il dottor Lewis sarebbe ritornato in serata per parlare di alcuni risultati, quindi c’era tutto il tempo per un riposino.
Squillò il telefono, era Lewis che le invitava nel suo studio.
Il dottore iniziò mostrando la lastra al torace sullo schermo luminoso. “Alcuni linfonodi sul mediastino appaiono ingrossati, Linda”.
“Cosa vuol dire? È un tumore? O sono già metastasi?” chiese lei.
Lewis fece il giro della scrivania e prese le mani di Linda. Le indicò, nell’incavo dorsale tra pollice e indice della mano destra, alcune piccole piaghette rosse. “Linda, con grande probabilità questo è un melanoma. Anche il piccolo neo tra il dito indice e il medio è coinvolto. Faremo una nuova biopsia del tessuto vicino”.
Erano ammutolite da quella notizia.
“Dottore, io mi sento bene! I nei potrebbero essersi ingrossati per il sole e il prurito che la sabbia provoca. Non è possibile. Non ci credo!” insistette Linda.
“Vedremo gli altri risultati nei prossimi giorni e poi decideremo il da farsi. Buona serata, signore”.
Neanche il loro respiro si sentiva in ascensore, ma nella suite esplose la rabbia di Linda verso Ana. “Hai insistito e mi ritrovo in questo casino! È una cazzata! Non è possibile che sia così! Tutta colpa delle tue paure! Io sto benissimo!”
Ana le augurò la buona notte e si ritirò nella sua stanza. Linda ordinò vino e cantò fino a mezzanotte.
Il mattino seguente, Lewis rimase perplesso nel vedere Linda salutare dalla finestra alcuni fan che erano giù all’ingresso dell’ospedale e cantavano sventolando fiori per lei. Era sorridente quando si voltò per ascoltare il dottore.
“È molto amata, vedo” disse Lewis accennando un mezzo sorriso.
“Sì! Perché sanno che il mio affetto per loro è sincero. Non fingo”.
Linda si sedette mantenendo la schiena orgogliosamente diritta e non rivolgendo lo sguardo all’amica.
“Sono qui per confermarle la diagnosi di melanoma. Ci sono piccole infiltrazioni linfovascolari che stanno cominciando ad ingrossare altri linfonodi. Tutto parte dalle prime tre dita della mano destra, come confermato dalla risonanza magnetica con contrasto. Abbiamo due strade che possiamo percorrere”. Lewis si fermò per riprendere fiato e concentrarsi sulle brutte notizie conclusive.
Linda si alzò di scatto andando nuovamente alla finestra per lanciare sue foto autografate agli ammiratori urlanti. Chiudendo la finestra disse al dottore: “Qual è la strada più breve?”
“Amputare le tre dita della mano destra per tentare di rallentare l’infiltrazione di cellule tumorali. Prima dell’amputazione ci sarebbero, tuttavia, tre cicli di chemioterapia per cicatrizzare il più possibile”. Lewis si fermò perché aveva visto il volto incredulo delle donne.
“E secondo lei mi faccio tagliare tre dita? Non basta fare la chemioterapia senza tagliare? E se le tagliassero a lei, le dita? No, dottore, questa strada non è per me. Mi prenderò del tempo per pensare, partiamo domani e poi le farò sapere” concluse Linda accendendosi una sigaretta.
“Non aspetti troppo, Linda. Ha il mio numero di telefono, mi chiami” disse lui tendendo la mano, che Linda non volle stringere.
Andarono via prima dell’alba il mattino dopo. Linda non rispose a nessuna domanda e proposta di Ana. Si ritrovarono negli studi televisivi dopo qualche giorno come se nulla fosse accaduto.
“Chiama Lewis, partiamo domani” disse Linda quasi senza voce. Si era presentata nell’ufficio di Ana scalza e claudicante. Gli ematomi sotto le unghie e le piante dei piedi ormai rendevano faticoso stare in piedi. Decisero tutto in quel momento: Linda avrebbe fatto con Ana un’ultima intervista. Ana avrebbe organizzato lo studio televisivo con le ultime foto fatte in Messico. Linda, dietro un ampio tavolo, sarebbe stata seduta normalmente nonostante la sedia a rotelle, il piccolo vaso di fiori rossi avrebbe coperto la mano mutilata mentre con l’altra avrebbe salutato in spagnolo il pubblico, una vez mas.
foto di Petra by Pixabay